Manlio Sgalambro in Incidenza, VIII, nn. 4-5, luglio-ottobre 1966, pp. 33-38
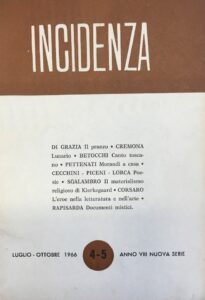
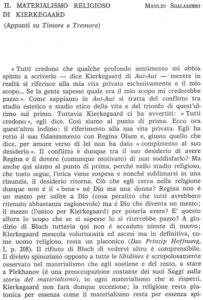
«Tutti credono che qualche profondo sentimento mi abbia spinto a scriverlo – dice Kierkegaard di Aut-Aut – mentre in realtà si riferisce alla mia vita privata esclusivamente e il mio scopo… Se qualcuno sapesse quale era il mio scopo mi crederebbe pazzo». Come sappiamo in Aut-Aut si tratta del conflitto tra stadio estetico e stadio etico della vita, e del trionfo di quest’ultimo sul primo. Tuttavia Kierkegaard ci ha avvertiti: «Tutti credono», egli dice. Così siamo al punto di prima. Ecco ora quest’altro indizio: il riferimento alla sua vita privata. Egli ha rotto il suo fidanzamento con Regina Olsen e, giusto quello che dice, per amore verso di lei non ha dato «compimento al suo desiderio». Il conflitto è dunque tra il suo desiderio di riavere Regina e il dovere (comunque motivato) di non soddisfarlo? Ma anche qui siamo al punto di prima, perché nello stadio religioso, che tosto segue, l’etica viene sospesa e nonché sublimarsi in una rinunzia, il desiderio ritorna. Ciò che egli cerca nella religione dunque non è il «bene» né Dio ma una donna? Regina non è un mezzo per salire a Dio (cosa che tutti peraltro avrebbero ritenuto abbastanza ragionevole e conforme allo spirito più puro della tradizione) ma è Dio che diventa un mezzo; il mezzo (l’unico per Kierkegaard) per poterla riavere? È questo allora lo scopo che se si sapesse lo si riterrebbe pazzo? A giudizio di Bloch tuttavia qui non è accaduto niente di nuovo; Kierkegaard mescola voluttuosità e ascesi ma in definitiva, come uomo religioso, resta un platonico (Das Prinzip Hoffnung, I, p. 208). Il rifiuto di Bloch di vedervi altro è comprensibile. Il divieto spinoziano opposto a tutte le libidines è scrupolosamente osservato nel materialismo che egli sostiene e del resto a stare a Plekhanov (è una preoccupazione costante dei suoi Saggi sulla storia del materialismo), in ogni materialismo che si rispetti. Kierkegaard non farà dunque eccezione; la religione resta platonica per essenza come il materialismo resta per essenza spinoziano. In realtà, se si considera la posizione realmente assunta da Kierkegaard, Bloch non ha tutti i torti; ce n’è un’altra che Kierkegaard assume nella fantasia ma non è certamente questa che si può invocare.
Si sa che Spinoza aveva celebrato il potere della rinunzia – la «potestas libidines coërcendi» – come il frutto supremo dell’«amor erga Deum»; è probabile che Kierkegaard, nel cavaliere della rassegnazione che rende possibile spiritualmente l’impossibile mediante la rinunzia, abbia di mira lui e quelle «res quæ in nostra potestate non sunt» ma che, sempre secondo Spinoza, possono in qualche modo diventarlo se seguiamo i dettami dell’etica che ci insegnano «utramque fortunæ faciem æquo animo expectare et ferre». Regina è una di queste «res» (come lo sono la maggior parte delle cose che desideriamo) e di fronte alla sua perdita Kierkegaard, non soltanto per la filosofia ma per ogni religione che si sia sottomessa a quell’ammaliante potere che dicevamo, non deve far altro che «expectare et ferre». Sarà questa infatti la posizione personale di Kierkegaard, che non andrà oltre la rassegnazione, ma non la fede che egli immagina in Timore e Tremore.
La singolarità di questa fantasia sta nel fatto che in essa si immagina che colui che compie interamente il movimento della fede non si ritroverà tra le mani il pugno di mosche dell’infinito e dello spirito, ma il finito o come anche si spingerà a chiamarlo l’impossibile e tutto questo, s’intende, non spiritualmente. Timore e Tremore, è stato detto, costituisce un tentativo infruttuoso per dire di sì al reale passando attraverso Dio; un tentativo fallito (J. Wahl, Études kierkegaardiennes, p. 206). Dirlo non costa niente; si prende Kierkegaard, si vede che egli non ha riavuto Regina e, posto che era questo che egli cercava attraverso la fede, se ne trae la dovuta conclusione. Ma ripercorriamo lentamente il tentativo, soffermandoci su ogni tappa con la stessa lentezza che certo dovette costare a chi lo effettuò. Cambia forse la conclusione? Per niente. Regina è perduta, e per sempre. Al di là però della vicenda personale, il cui misero esito del resto Kierkegaard ha scontato premettendo che egli non aveva la fede, resta ciò che ha immaginato.
Se dobbiamo credere a quanto Kierkegaard nella Postilla conclusiva non scientifica dirà di Feuerbach e ciò che questi «attacca il cristianesimo e l’espone nello stesso tempo in modo così notevole che è una gioia leggerlo, e chi non sa dove indirizzarsi per vederlo esposto in maniera precisa è quasi obbligato a ricorrere a lui», il sospetto, già esternato da Adorno (Kierkegaard, la costruzione dell’estetico, p. 107), che dietro l’intenzione ironico-dialettica delle sue parole si possa nascondere una segreta affinità, potrebbe ricevere conferma. Nell’Essenza del cristianesimo Feuerbarch aveva osservato: «Il desiderio non riconosce nessun limite, nessuna legge, nessuna temporalità; vuole essere appagato senza indugio, istantaneamente»; il mistero della fede è questo: «la fede fa sì che sia ciò che l’uomo desidera». Sono, come ognuno può vedere, gli stessi presupposti di Timore e Tremore; salvo che ciò che per l’uno né è la critica, per l’altro è la religione. Se Dio è il mezzo e lo scopo è il finito, quello che si trovera in Timore e Tremore – e non ci si libera dall’impressione che sia volutamente contrapposto alla critica materialista della religione di Feuerbach, – si può senz’altro definire un rovesciamento materialistico della religione ma all’interno della religione.
Questo ci riporta all’estetica o meglio a quella mescolanza di estetica e religione su cui Kierkegaard riferirà abilmente – affermandola e mascherandola – nel Punto di vista sulla mia attività di scrittore. Come un autore religioso, si domanda egli qui, s’è potuto convincere a ricorrere all’estetica? Vedremo più oltre la sua tranquillizzante risposta; per intanto conosciamo già un elemento comune ad entrambe, il solo che egli non ha voluto mascherare, il desiderio. Ecco però che daccapo ci sbarra la strada: la fede, dice perentoriamente, non è un impulso di carattere estetico. Ci concederà Kierkegaard che può diventarlo? Che può diventare una dissipazione, il culmine della sregolatezza, il più squisito dei piaceri, la crapula assoluta? E che in ogni caso qui lo è diventata? Non dobbiamo infatti dimenticare l’affermazione di principio che regge Timore e Tremore: «mediante la fede, io non rinunzio a nulla; anzi ricevo tutto…». L’impurità della fede è legittimata.
C’è sempre una fessura attraverso la quale l’estetica si insinua, raccatta ciò che l’etica lascia cadere incurante e trionfa. Per tornare a Spinoza, la sua amara ammissione che «quæ plerumque in vita occurrunt, et apud homines… tanquam summum boum æstimantur, ad hæc tria redinguntur, divitias scilicet, honorem atque libidinem» è controbattuta dalla sua certezza che le «res æternæ» alla fine prevarranno. Anche se gli uomini «crederent mentes cum corpore interire» ritenere che si darebbero al capriccio e si regolerebbero in base al proprio piacere è, dice ancora Spinoza, altrettanto assurdo quanto pensare che uno preferisca essere pazzo e vivere senza ragione. Spinoza non prevede che la sfida sarà raccolta; che uomini che faranno professione di assurdità pretenderanno di raggiungere ex libidine quegli scopi per cui egli riteneva di avere indicato l’unica strada possibile. De Sade, che precederà l’esteta kierkegaardiano in questa aggressione dell’estetica all’etica nonché all’incontro tra estetica e religione, non esiterà a dire: «Lungi dal negare Dio come l’ateo o di lavarlo dei suoi torti come il deista» il libertino si impegna – per usare le parole di Klossowki (Le mal et la négation d’autrui dans la philosophie de De Sade) – in una provocazione di Dio «come se lo scandalo fosse un mezzo per forzare Dio a manifestare la sua esistenza». «Se vi fosse un dio e questo dio avesse la potenza, permetterebbe che la virtù che l’onora e di cui voi fate professione fosse sacrificata come essa va ad esserlo ai vizi e al libertinaggio…?», chiede De Sade nelle 120 Journées de Sodome, ed è senza dubbio una domanda estetica e religiosa nello stesso tempo. Le «futili» osservazioni di Noirceuil, in Juliette, sulla differenza tra amare e godere e sulla nessuna importanza della bellezza del collo o della leggiadra curva di un fianco per chi ama o della loro assoluta importanza per chi mira all’illimitato possesso dell’altro; quelle di Giovanni, nel Diario del seduttore kierkegaardiano, sul delizioso piedino di Cordelia e sulla sua mano candidissima, mirano tutte più lontano. Impegnano l’estetica oltre i suoi naturali confini; concernono, che avvenga in nome dell’incredulità o della fede, i diritti dell’uomo al finito.
Nel Punto di vista sulla mia attività di scrittore, rispondendo alla domanda che sopra abbiamo riportata, Kierkegaard presenta l’estetica come il dosaggio degli effetti che devono preparare un’efficace entrata in scena dell’elemento religioso; sembra di sentire Hegel: «la religione si serve molto spesso dell’arte per avvicinare al sentimento o per portare ad immaginare per la fantasia la verità religiosa». Dallo stesso Kierkegaard noi sappiamo invece che l’estetica non è innocua, che essa non lascia intatto niente di ciò con cui ha a che fare, che sporca tutto imprimendovi il marchio delle sue esigenze. La fede che passa attraverso l’estetica non vi passa impunemente; diventa, come abbiamo visto, una fede che non intende rinunziare a nessuna cosa ma vuole tutto, qui, in questo mondo: «Abramo credeva. Egli non credeva che un giorno sarebbe stato felice nell’al di là; no, egli credeva che qui stesso, in questo mondo, sarebbe stato felice» (Timore e Tremore).
Ciò che si fa luce dunque attraverso l’estetica così com’è, ma modificato dal desiderio; l’elemento estetico per Kierkegaard, come quello economico per alcuni suoi contemporanei, rappresenta la scoperta del finito, mentre la fede per lui, la rivoluzione per costoro, ciò che dovrà rimettercene in processo. Ma da nessun altro luogo che dalla fantasia Kierkegaard può trarre il protagonista di questa fede: perché, chi ha creduto fino al punto da riavere il mondo non così com’è ma trasformato dal proprio desiderio? Nel descriverlo anche il suo linguaggio si fa finito; se vogliamo trovare qualcosa che lo identifichi troviamo questo: «lo si scambierebbe con droghiere in vacanza», «ha tutta l’aria di un agente delle imposte», «chi lo vedesse potrebbe scommettere che è un salumiere». Egli immagina così: «Lo esamino dalla testa ai piedi cercando la fessura attraverso la quale si riveli l’infinito. Nulla! È solido in ogni punto. Il suo passo? Tranquillo, interamente confidato al finito… È completamente di questo mondo, come nessun bottegaio saprebbe esserlo di più». Sembrerebbe che dialetticamente costui avesse trasformato il finito in infinito e che si fosse conciliato col mondo così com’è; niente affatto, il finito è rimasto tale e quale (a tutto egli pensa fuorché alle «res æternæ» ma tornando a casa la sera a una «testina di capretto, arrosto, forse con contorno» che troverà per cena) e l’infinito pure e «tutta l’immagine del mondo che egli produce è una creazione nuova dovuta all’assurdo». Kierkegaard gioca qui col finito come il gatto col topo? No, ma poeta fino all’ultimo (l’estetica non restituisce mai più le sue vittime) egli non può che immaginare. Tuttavia il primato accordato alle immagini ha una ragione più profonda. «Il regno dell’estetico – commenta Adorno – … riceve la sua struttura dalle immagini che appaiono al desiderio, ma che non sono da esso prodotte, perché il desiderio stesso scaturisce da loro». Compendio di tali immagini, egli aggiunge, è l’immagine del mondo migliore che costituisce il più importante retaggio dell’estetica «in quanto cellula di un materialismo che va in cerca del mondo migliore non per dimenticare sognando quello presente ma per modificarlo». Tutto questo trova conferma in quanto Kierkegaard stesso ha detto in un passo del Punto di vista sulla mia attività di scrittore: «Il religioso… è la riproduzione trasfigurata nell’eternità del più bel sogno della politica». Ma, conclude, è impossibile realizzarlo qui. Tuttavia, non è in virtù dell’assurdo, secondo ciò che ha immaginato, che chi ha fede otterrà l’impossibile e l’otterrà qui e non nell’eterno, non importa se Isacco, Regina o il mondo migliore?
Questa fede che Kierkegaard immagina, capace di ridarci il mondo e per di più mutato secondo i nostri desideri, si ricongiunge nell’essenziale a quel materialismo che nello stesso tempo aspirava allo stesso fine. Il posto di Timore e Tremore non può essere che qui; in comune con esso ha quello che qualcuno chiamò «il sogno di una cosa…» e la convinzione che per avere l’impossibile occorre l’impossibile. Dio per Kierkegaard, la rivoluzione per l’incredulo Marx, ma l’impossibile.